di Vito Bianco
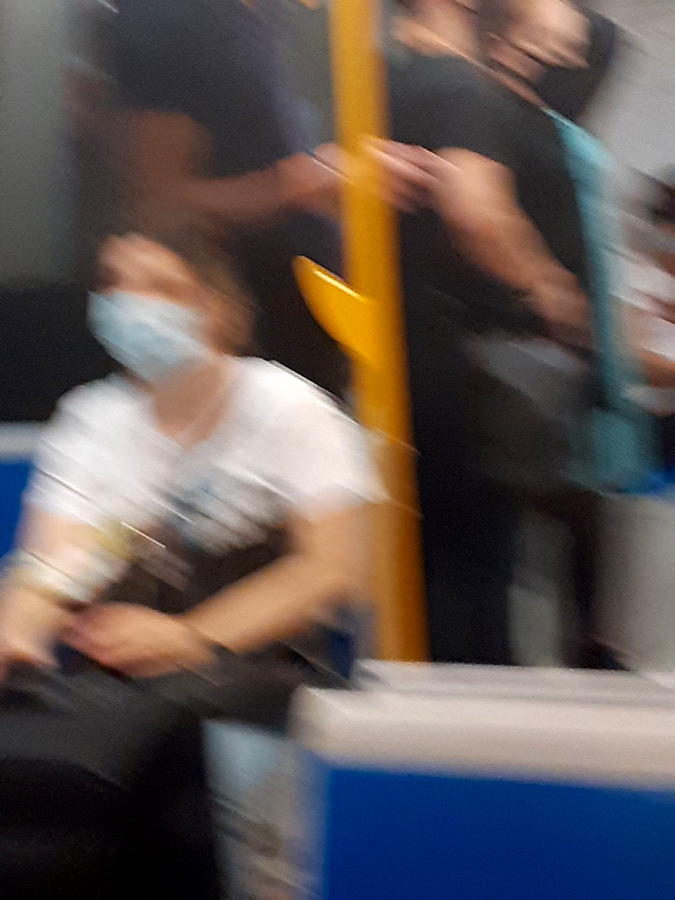
Oggi è domenica, c’è silenzio, ma non è il solito silenzio domenicale, ha il sapore dell’attesa, del tempo breve e sospeso che prelude a qualcosa che conosciamo bene per esserci passati nella scorsa primavera, quando per due mesi e mezzo le strade sono rimaste vuote e davanti ai supermercati, ai tabaccai, agli uffici postali le file erano lunghe e silenziose come le vie le piazze le gallerie e i parchi. Da un paio di settimane, forse tre, anche le ambulanze hanno ricominciato a farsi sentire con una frequenza inquietante, le sirene spiegate che sono un urlo un lamento una pena sparsa per l’aria sotto le finestre dei palazzi lungo la via principale che in un unico rettifilo esce dalla piccola città e porta al Parco Nord e all’Ospedale Bassini. Ieri mattina siamo andati al supermercato a far scorta di pizze e altri surgelati, è inutile far finta che tutto possa andare avanti così per molto, i numeri parlano chiaro, crescono i contagi, i ricoverati, e come ad aprile Milano e la Lombardia registrano le punte più alte di positivi, ricoverati e accessi ai pronto soccorso, da almeno dieci giorni seriamente in affanno. Nel pomeriggio vado a Milano (prima che chiudano tutto, mi dico): autobus fino a San Giovanni e metro rossa. Poca gente sul bus, un po’ più affollati i vagoni del metrò. Anche al Duomo e nelle vie adiacenti non c’è la folla dei sabati normali, la ressa nei negozi, il via vai nelle gallerie, nei caffè, allo Store della Mondadori sotto i portici, i turisti che si fotografano sullo sfondo della grande chiesa gotica. In via Vittorio Emanuele una mostra di gigantografie a colori e in bianco e nero inneggiano alla speranza (in inglese, hope) mostrando l’interno delle sale di rianimazione, ritratti di medici e infermieri e scatti che inquadrano la vicinissima piazza Duomo con le contestate palme deserta, lunare: un memento di quello che è stato e potrebbe ancora essere. Mi lascio alle spalle piazza Fontana di dolorosa memoria (il giardinetto, la fontana con le tre vasche circolari e le panchine, il sobrio Palazzo arcivescovile) e attraverso via Festa del perdono restando a ridosso della bella e lunga facciata del palazzo dell’università. Non incrocio nessuno, nessuno ai tavoli dei locali, soltanto poco prima una corta fila di persone in mascherina davanti a quella che mi sembra, per la luce verde dell’insegna, una farmacia. Corso di Porta Romana, col suo caratteristico miscuglio di bello e brutto, che è, si può dire, la cifra dominante di questa metropoli a volte indecisa ma dinamica, energica, volitiva, che sa promettere ma non sempre mantenere, accogliente ma con un fondo di distacco, di lontananza, quella sentita e detta con ironica malinconia da Luciano Bianciardi nella Vita agra , o, nelle pagine del Padrone del veneto Parise, vista con gli occhi ingenui del ventenne provinciale sedotto dallo spettacolo di palazzi di vetro, strade, vetrine di negozi (“Ho camminato, camminato e camminato, senza stancarmi mai di guardare le case, le strade, i negozi, i cinematografi, l’immenso fiume di automobili che correva strombettando allegramente come per giocare e la gente che camminava accanto a me sui marciapiedi”) negli stessi anni affluenti e “beati” che però incubavano le crepe, la malattia e le morti che arriveranno alla fine del decennio.
Gli sguardi sopra il bordo delle mascherine celesti sono seri. Ma lo sono o sono io a proiettare negli occhi che incontro la mia serietà ansiosa, preoccupata? Svolto in via Orti, dove al 19 c’è la nuova sede della libreria Einaudi, da dieci anni punto di riferimento culturale per l’intero quartiere. Fabio, il libraio siciliano che vie a Milano da dieci anni, mi ha messo da parte i libri che avevo ordinato, ma ne prendo anche altri: Enzesberger, Revelli, Walter Siti, del quale non ho ancora letto nulla. Chiacchieriamo, e scopro che il suo pessimismo sul futuro prossimo fa il paio con il mio, che immagino sia anche quello di molti. Mi dice che la presentazione dell’ultimo libro di Nicola Lagioia al teatro Franco Parenti è saltata, “ma lui è passato in libreria a firmare una ventina di copie”, che sono impilate in due colonne in un angolo subito dopo l’ingresso. È già buio quando lo saluto ed esco con sulle spalle la “legna spirituale” per il freddo inverno che si annuncia. Ritrovo il corso e le sue diradate presenze, passanti che si affrettano senza neppure gettare un’occhiata alle vetrine, rider in bicicletta che cominciano il loro malpagato giro di consegne a domicilio. Attraverso piazza Beccaria, una delle mie preferite, e raggiungo San Babila, dove i lavori in corso non hanno voglia di finire. Scendo le scale della metro e mi torna in mente il racconto di Cort á zar sugli uomini che vivono in questo sottomondo rinunciando alla luce del sole e trasformandosi in strane creature della penombra perenne. Trovo posto accanto a una ragazza con i capelli rossi e le dita sottili che si muovono veloci sulla tastiera del telefono. Cerco di leggere quello che scrive ma non ci riesco. Mi tolgo gli occhiali e chiudo gli occhi per un minuto. Un’ora dopo sono a casa, proprio ne l momento in cui parte il sommario del primo telegiornale della sera.
